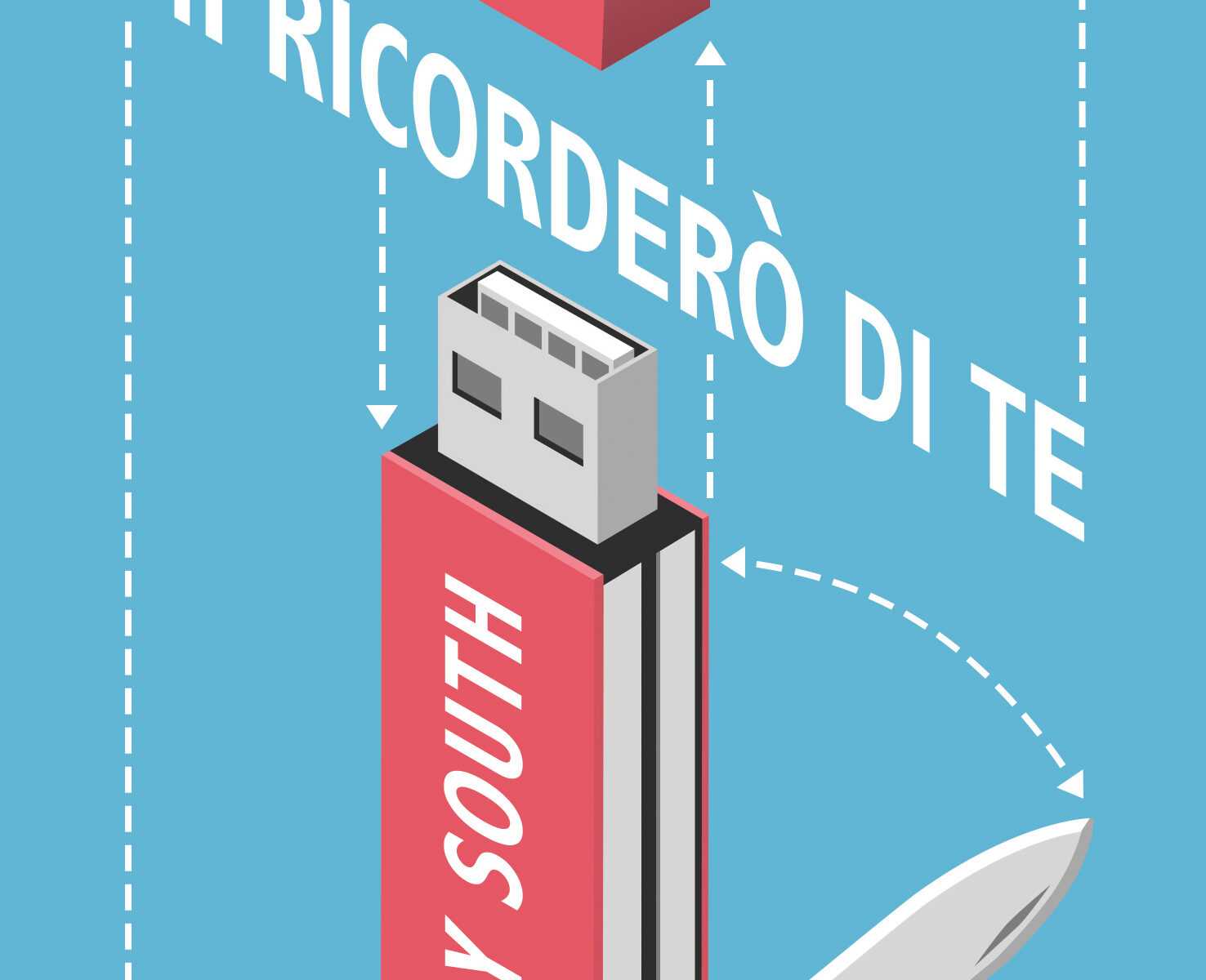Ogni volta che l’ufficio stampa di Pidgin mi scrive per propormi in lettura una delle sue produzioni mi si riempie il cuore di gioia. E non esagero. Ogni volta che apro uno di quei mondi di carta messi in giro da una delle realtà editoriali più interessanti della nostra nazione non vengo deluso. È successo con Il libro di X di Sarah Rose Etter ed è successo anche questa volta con l’antologia di racconti Mi ricorderò di te di Mary South. Pidgin edizioni infatti, oltre a pubblicare libri sopra le righe, estremi, di autori sia italiani che stranieri – e questo già dovrebbe essere sufficiente per il lettore novocarnista – ha anche un’atteggiamento ben preciso all’interno del panorama editoriale, che come molti sappiamo, è spesso inquinato da fattori che con la letteratura c’entrano poco e niente (e non sto parlando di qualità, ma di politica vera e propria, anche se viene fatta tra le bancarelle di una fiera realmente indipendente e non in Parlamento).
D’accordo, basta con i pistolotti e parliamo del libro. L’autrice, statunitense, ha pubblicato su diverse riviste americane e con questa antologia si è imposta alla critica oltreoceano che conta. L’antologia contiene dieci racconti che spaziano dal what if di matrice blackmirroriana a visioni di ballardiana memoria annaffiate con l’acqua (acida) della nostra società post-capitalistica. La tecnologia, internet, i rapporti sociali disgregati, la vecchiaia, l’arte, il disagio interiore, le relazioni a pezzi, sono solo alcuni dei temi affrontati e che i personaggi si trovano a vivere all’interno di narrazioni dallo stile ironico e sottile, che però allo stesso tempo non risulta mai stucchevole o troppo ammiccante.

In Keith Prime si parla di cloni, come dicevo, alla Black Mirror, con tanto di sospensione dell’incredulità e domande irrisolte sull’umano. Ne L’età dell’amore, racconto dalle tinte meno fantascientifiche, un operatore di una RSA inizia a registrare le chiamate che gli ospiti della struttura fanno alla linea erotica, non sapendo che quello che era un scherzo arriverà a compromettere la sua relazione. I successivi Domande frequenti sulla tua craniotomia e Architettura per mostri, credo i miei preferiti della raccolta, riprendono alcuni temi cari a certa letteratura post-moderna, giocando con termini e questioni mediche (il primo) e artistiche (il secondo), con un’apparente freddezza che non riesce a non invadere prepotentemente la dimensione individuale. Anche Per salvare l’Universo… e L’ostello promesso affondano nel metagenere del post-moderno, il primo giocando e portando alle estreme conseguenze il concetto di fandom, il secondo con le sue situazioni e relazioni grottesche. Mi ricorderò di te e Campeggio Giabervocco… affrontano in maniera più diretta la questione di quanto Internet consumi dall’interno le nostre relazioni ma allo stesso tempo fornisca nuove opportunità di connessione; oscilliamo quindi dalla disgegazione personale dovuta ai social network alla “cura” della malattia da trolling. Chiudono la raccolta una sorta di weird story da paradiso gentrificato (L’agente immobiliare dei dannati) e un romantico quanto sconvolgente dramma familiare (Non è Setsuko).
Ci tengo poi a fare i complimenti al lavoro certosino dell’editore, Stefano Pirone, che ha curato sia la traduzione, che l’impaginazione, confezionando un vero e proprio gioiello della parola.
Un capolavoro? Vi risponderò con una storia. Qualche mese fa ho partecipato a un incontro sull’editoria e gli argomenti erano: quanti libri di producono, quanti se ne vendono, i problemi della distribuzione in Italia, ecc. Il relatore ci ha aperto gli occhi su quanto siano diffusi i pregiudizi su quanto si legge e quanto si vende, ma al di là dei numeri, una frase mi ha colpito: al giorno d’oggi tutti parlano di capolavori, al fine di pubblicizzare il proprio prodotto, ma questo modo di fare ha avuto, nel tempo, l’effetto di anestetizzare il pubblico con milioni di titoli “capolavoro” che vengono sfornati ogni minuto, e per questo lo stesso termine ha perso di significato e non indica più, o almeno non sempre, quello che letteralmente significa, ovvero un libro che dovrebbe finire sui libri di letteratura tra qualche decennio. Ed ecco la mia riposta alla domanda che facevo. Mi ricorderò di te mi ha colpito molto, molto di più di tante altre cose che ho letto quest’anno, delle nuove proposte, italiane e straniere, è sicuramente la migliore in assoluto, e che Mary South abbia la stoffa per scrivere un capolavoro, questo sì, posso affermarlo senza dubbio, perché questa antologia, se non in cima alla piramide della perfezione letteraria (almeno secondo i miei gusti) allora si trova appena appena sotto.