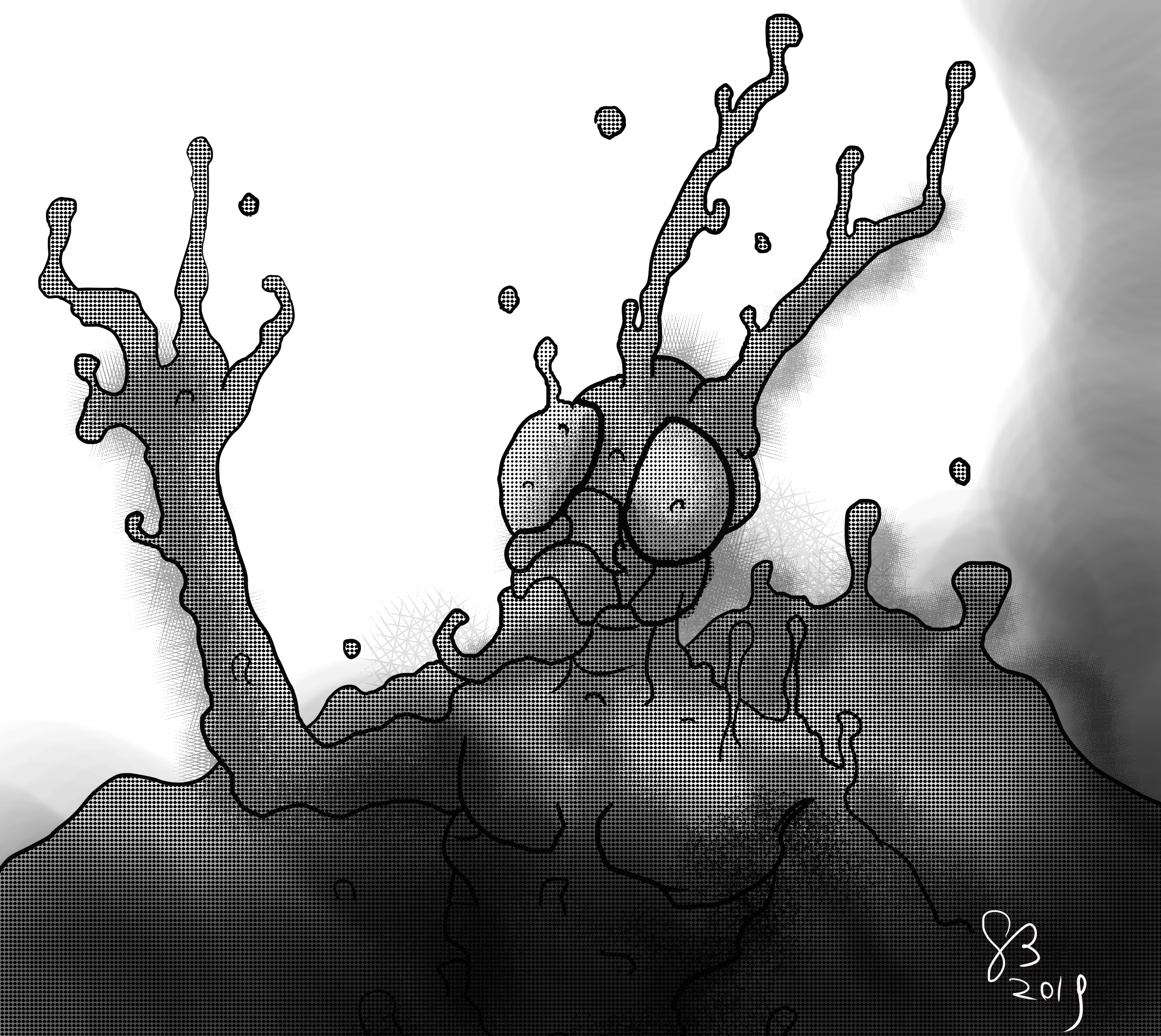Dopo la laurea in Lettere presso l’Università di Pisa e il diploma in Fumetto conseguito presso la Scuola Internazionale di Comics di Firenze, ha curato e tradotto le edizioni di Frankenstein di Mary Shelley per Feltrinelli e di Dracula di Bram Stoker per Barbera. Ha inoltre tradotto La Lettera Scarlatta di Hawthorne per Liberamente e Io morirò domani, un thriller di Dawood Ali McCallum edito da Giunti. Sempre per Liberamente ha pubblicato un manuale di Letteratura Italiana per studenti. Da sempre appassionato di fumetti, ha collaborato con BD e J-pop per la traduzione di graphic novel come Parker di Darvyn Cooke, Body Bags di Jason Pearson, Battlechasers di Joe Madureira e della serie manga The Legend of Zelda, Warcraft, Starcraft. Da sceneggiatore di fumetti collabora con Astromica che pubblica a episodi tre fumetti tratti da suoi testi: Dead and Alive, Orrore d’Autunno e Una nottataccia per Lemmy Black. Come docente ha insegnato “traduzione del fumetto” in un master universitario di II livello a Pisa, ha tenuto un workshop per la Scuola Fenysia di Firenze sulla letteratura horror e ha insegnato materie letterarie ai bambini e ai detenuti del carcere di Sollicciano. Due suoi racconti brevi figurano sulle antologie horror La serra trema volume 1 e 2 di Dunwich Edizioni. Dal 2015 a oggi ha prodotto alcuni audiolibri tratti da suoi racconti di varia durata in mp3, con all’interpretazione dell’attore e doppiatore Edoardo Camponeschi (Midnight Club, Orrore d’Autunno, Hello Darkness, Zombie Mutation). Framax Audiolibri ha realizzato la versione audio di Satyros, un suo romanzo breve originariamente commissionatogli dalla Community Escrivere.com. Come illustratore realizza con tecnica digitale opere fantasy, horror e di fantascienza che compaiono in numerose copertine di Anonima GDR webzine e sul volume 1 della nuova edizione della antologia digitale Altrisogni, edita da Dbooks. Una sua illustrazione compare nel manuale del gioco di ruolo Charme. La sua ultima pubblicazione, sempre per Framax, è una traduzione con raccolta di saggi del Reanimator di Lovecraft. Come attore compare in diversi cortometraggi, come il fantascientifico Black Hole e l’horror È solo un gioco di Leonardo Barone. Ha fatto lo zombie in Zombie Massacre di Boni e Ristori e ha recitato la parte di un dark fuori di testa in Go Dante, Go! Go! Go! di Alessio Nencioni. Pratica la MT ma è ancora scettico e modella in 3d cravatte texane così tamarre che indossa solo lui.

Dopo la laurea in Lettere presso l’Università di Pisa e il diploma in Fumetto conseguito presso la Scuola Internazionale di Comics di Firenze, ha curato e tradotto le edizioni di Frankenstein di Mary Shelley per Feltrinelli e di Dracula di Bram Stoker per Barbera. Ha inoltre tradotto La Lettera Scarlatta di Hawthorne per Liberamente e Io morirò domani, un thriller di Dawood Ali McCallum edito da Giunti. Sempre per Liberamente ha pubblicato un manuale di Letteratura Italiana per studenti. Da sempre appassionato di fumetti, ha collaborato con BD e J-pop per la traduzione di graphic novel come Parker di Darvyn Cooke, Body Bags di Jason Pearson, Battlechasers di Joe Madureira e della serie manga The Legend of Zelda, Warcraft, Starcraft. Da sceneggiatore di fumetti collabora con Astromica che pubblica a episodi tre fumetti tratti da suoi testi: Dead and Alive, Orrore d’Autunno e Una nottataccia per Lemmy Black. Come docente ha insegnato “traduzione del fumetto” in un master universitario di II livello a Pisa, ha tenuto un workshop per la Scuola Fenysia di Firenze sulla letteratura horror e ha insegnato materie letterarie ai bambini e ai detenuti del carcere di Sollicciano. Due suoi racconti brevi figurano sulle antologie horror La serra trema volume 1 e 2 di Dunwich Edizioni. Dal 2015 a oggi ha prodotto alcuni audiolibri tratti da suoi racconti di varia durata in mp3, con all’interpretazione dell’attore e doppiatore Edoardo Camponeschi (Midnight Club, Orrore d’Autunno, Hello Darkness, Zombie Mutation). Framax Audiolibri ha realizzato la versione audio di Satyros, un suo romanzo breve originariamente commissionatogli dalla Community Escrivere.com. Come illustratore realizza con tecnica digitale opere fantasy, horror e di fantascienza che compaiono in numerose copertine di Anonima GDR webzine e sul volume 1 della nuova edizione della antologia digitale Altrisogni, edita da Dbooks. Una sua illustrazione compare nel manuale del gioco di ruolo Charme. La sua ultima pubblicazione, sempre per Framax, è una traduzione con raccolta di saggi del Reanimator di Lovecraft. Come attore compare in diversi cortometraggi, come il fantascientifico Black Hole e l’horror È solo un gioco di Leonardo Barone. Ha fatto lo zombie in Zombie Massacre di Boni e Ristori e ha recitato la parte di un dark fuori di testa in Go Dante, Go! Go! Go! di Alessio Nencioni. Pratica la MT ma è ancora scettico e modella in 3d cravatte texane così tamarre che indossa solo lui.
Mindlag [Finale]
Aveva smesso di chiedersi come fosse arrivato a casa sull’onda di un sussulto improvviso, quando si era visto riflesso nello specchio ovale dell’ascensore. La sua camicia bianca era divenuta rossa, mentre il suo volto era una maschera di sangue rappreso. Sulla fronte i bordi rigonfi di un taglio combaciavano con il lungo grilletto di accelerazione della cloche. Bog ricordava le cifre dell’orologio olografico: pur sottosopra, decretavano spietate che mancava un’ora a mezzanotte. Ricordava anche il rumore di lamiera e lo sportello che si apriva a fatica, poi era stato partorito nella notte piovosa e aveva pensato solo a correre, fra i lavoratroni e il loro cigolio. La sua lucidità era scomparsa nella tempesta di minacce dalle voci metalliche, una cantilena di “Violazione!” declamata in tono così neutro da divenire un’eco.
. Ma adesso Bog era di fronte alla porta di casa. Non gli sembrava vero.
Certo, lo avrebbero preso, quando avrebbero sfondato la porta forse lo avrebbero trovato connesso. Sarebbe stata l’ultima connessione, prima di una vita da miserabile, ai margini della società, ma in fondo che importava?
La porta del suo mono non si aprì subito, per via della mano resa viscida dal sangue, o forse a causa del tremore. Premette con forza il pollice nel riquadro della serratura, e alla fine quella scattò.
Con un sorriso beato sulle labbra, Bog non si curò del rosso che disseminava per il pavimento, perché tanto la sua vista diveniva sempre più annebbiata e tutto si stava mutando in un grigio appannato.
Riuscì a distinguere solo la smartchair al centro della stanza, uno scorpione nero con la testiera proprio sulla coda, tuttavia prese male le misure e inciampò su una delle zampe cadendovi sopra.
Il dolore gli percorse tutto il corpo e gli venne da pensare che l’avvoltoio: quel finto medico del Pervernet aveva ragione sulla testiera portatile. Gli avrebbe risparmiato quella giornata di merda.
Bog poggiò la nuca sul cuscino e avvertì che il sangue ne insozzava la pelle sintetica, fece un rumore viscido che lo fece sorridere, ma non ridere, perché qualsiasi movimento corrispondeva a una stilettata.
L’ago lo trafisse immediatamente e tutto cambiò. Il suo mono divenne la Hall del Pervernet e anche il dolore sparì quando divenne un altro: Slavus Maximus.
Sulla schiena le ali da falena erano un mantello che lo ricopriva, lo confortava, spandevano polvere ogni volta che si muoveva. Più del solito. Doveva cercare Domina Strix, ma non aveva idea di dove fosse. L’istinto gli disse di cercare nella stanza più vicina, o forse sperava di trovarla lì, perché si sentiva debole, troppo debole.
Bog sollevò la pesante tenda dell’ingresso e lasciò sulla stoffa una costellazione di sabbia argentea, ma non se ne curò. Non avrebbe potuto usare le ali per volare, le sentiva sempre più leggere, in disfacimento, così camminò sulle sue due zampe da insetto, le coxe ruotavano ritmicamente e sempre più fragili, i suoi movimenti erano sempre più goffi nell’aggirarsi per l’ambiente. I pervertiti gommosi si accoppiavano formando una catena di carne, i loro Skinavatar producevano il rumore di palloncini sfregati insieme. Mani umide, protuberanze rugiadose e filamenti lo toccarono, cercando di fermarlo, ma la polvere che lasciava su di loro li faceva ritrarre.
A un tratto si sentì afferrare per la caviglia e si girò di scatto, la punta lanuginosa di un’ala si dissolse in un polline evanescente. Prona, su quattro zampe flaccide, una bestia dalla pelle di medusa lo fissava: Slavus Maximus lo percepì, anche se quella al posto degli occhi e della bocca aveva tre sfinteri. July “Anal” Großebecken, diceva il cartello sul palo che le spuntava dalle natiche del suo Skinavatar nuovo di zecca, ma sempre dozzinale. L’ibrido umano-falena cominciò ad agitarsi, ma, fiacco come era, i suoi tentativi somigliavano a quelli di un insetto stretto in pugno da un moccioso, e poi era terribilmente difficile liberarsi dalla stretta di quelle mani gelatinose. Come se non bastasse, i seni di July toccavano terra ed erano una sorta di zavorra che sgorgava un latte fluorescente.
Slavus Maximus diede uno strattone e rischiò di inciampare su quella pozza, ottenne solo che un’antenna gli si staccasse dal capo in uno sbuffo di polvere. Si sporse verso di lei, gli sfinteri su quella faccia gommosa si rilassarono, quasi pregustassero la penetrazione che lui avrebbe dovuto concederle, invece Slavus Maximus afferrò il palo che le sbucava dal culo e lo estrasse. I quattro sfinteri risuonarono all’unisono esalando piccoli geyser vaporosi e squirtarono qualche lapillo di merda.
Slavus ne tappò uno infilandoci il palo con tutta la forza che aveva, con tanta violenza che l’esoscheletro che gli ricopriva una mano si disintegrò lasciando intravedere la pelle rosa. Quella della sua vera immagine.
Lasciò July a contorcersi, le grasse mani artigliavano i seni che spruzzavano due getti bianchi: stava soffrendo? Stava godendo? Cosa importava, in quel mondo di nulla che per Slavus era tutto? Quella puttana invadente aveva avuto quel che meritava, e lui invece no. Avrebbe voluto gridare il nome di Domina Strix con rabbia, obbligarla a manifestarsi e dare anche a lui la sua punizione, in nome della catena alimentare, in nome di un’esistenza-non esistenza. Invece Slavus Maximus arrancò in una nube di polvere che emanava lui stesso, il latte di July stava divenendo un lago. Solo allora capì che era la stanza del latte quella che avrebbe dovuto esplorare.
“Idiota! Idiota che non sei altro!” pensò, le lacrime scendevano dai suoi grandi occhi sfaccettati, che si portavano via frammenti cristallini.
Rischiando di andarsi a schiantare, volò, in modo maldestro, con fatica, spandendo polvere ovunque, lasciando dietro di sé una scia di cristalli. Gli parve di sentire le risate di tutti i pervertiti che si accoppiavano o si torturavano lì attorno, anche se non poteva essere vero. In quella massa proteiforme e contorta vedeva il Gran Briccone. Lo vedeva nei volti animaleschi, nei sessi turgidi e comunque nelle bocche schiuse vedeva sempre una risata.
Solo il candore della stanza del latte gli tolse dalla mente quel baccano inesistente, quel caos che si agitava e lo confondeva. Aveva bisogno solo di una certezza, e quella era Domina Strix.
La stanza era deserta e lei lo stava aspettando, lo osservava dall’alto. Il cuore gli finì in gola nel momento in cui la vide fluttuare in aria, il bianco delle mura di latte e il bianco della sua pelle si confondevano.
Questa volta niente ali da arpia, niente mutazioni: era completamente nuda e volava, come se galleggiasse, fra cascate di luce e un cielo che non esisteva. Il volto di lei era coperto da un velo di seta azzurro, il panneggio si muoveva lieve mentre lei discendeva.
Slavus Maximus cadde in ginocchio, la polvere del suo Skinavatar esplose, prima di dissolversi in un mulinello, quando Domina rimase sospesa a pochi centimetri dal pavimento liquido, dinanzi a lui.
Fremeva d’ira, la sua padrona, e questo lui lo comprendeva, perché si era fatto attendere, ma era lì per lei, per farsi punire.
Avrebbe accettato tutto.
Cosa aspettava, quindi? Domina Strix rimaneva immobile, come sbigottita dinanzi al suo disfacimento, alla polvere che adesso lasciava scoperta la proiezione del suo vero corpo.
“Tu…” disse Domina Strix, e Bog finse di non riconoscere quella voce, così come finse di non essere ormai completamente nudo, la sua identità svelata.
Non servì a nulla illudersi, o invocare una disconnessione da shock: Domina Strix, la sua padrona, scandì quelle tre ultime parole in un misto roco di disprezzo e rabbia.
“Schifoso, lurido paria!”

QUESTO RACCONTO FA PARTE DELL’UNIVERSO DI “MIDNIGHT CLUB”… chi è curioso può trovarlo in versione audiolibro su Audible, Storytel, Il Narratore e altri stores.